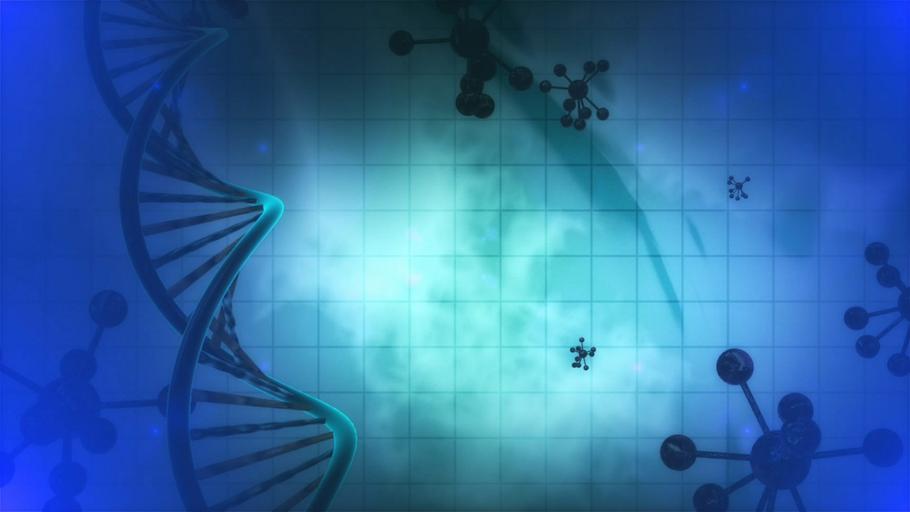Biologia e biologismo: quale linea di discrimine?
Come mostrato dall’ormai classico libro Il leviatano e la pompa ad aria. Hobbes, Boyle e la cultura dell'esperimento di Steven Shapin e Simon Schaffer (1983), la rivoluzione scientifica che nel corso del diciassettesimo secolo portò al costituirsi ed all’affermarsi di quella particolare forma di conoscenza della realtà che è per l’appunto la scienza moderna fu un processo che concernette non solo gli aspetti puramente epistemici del nostro rapporto alla realtà, bensì anche il significato più generalmente sociale e la dimensione anche politica di tale nuova forma di conoscenza del reale. In particolare, i nuovi metodi e le nuove tecniche sperimentali che vennero sviluppati in quel periodo da Galieo in Italia e dai seguaci dell’empirismo di Francis Bacon in Inghilterra ebbero come conseguenza anche il costituirsi di nuove società scientifiche (come ad esempio la Royal Society in Inghilterra, preceduta qualche decennio prima dall’Accademia del Cimento in Italia, che però non ebbe vita lunga). Tali società, nelle quali andava coagulandosi quella che oggigiorno viene chiama la comunità scientifica, erano non solo dei centri di elaborazione del nuovo sapere, bensì anche importanti promotrici di pubblicazioni e più generalmente di iniziative finalizzate alla formazione dell’opinione pubblica.
L’opera filosofica di Thomas Hobbes rappresenta un buon esempio di come le nuove concezioni della realtà che andavano emergendo nel corso della rivoluzione scientifica avessero dei riflessi importanti anche nella sfera delle idee attinenti alla politica ed all’organizzazione della società. Nonostante Hobbes avesse espresso delle riserve rispetto al valore dei nuovi metodi sperimentali promossi dalla Royal Society (come mostrato dal libro di Shapin e Schaffer), egli aveva infatti abbracciato la filosofia atomista e materialista che cominciava a soppiantare, all’epoca, le concezioni teologizzanti del medioevo feudale. Sulla base di tali nuove idee, Hobbes elaborò innanzitutto una teoria della natura umana – secondo la quale il bellum omnium contra omnes rappresenterebbe lo stato naturale (vale a dire prepolitico) dell’umanità – e poi una teoria politica – la teoria del contratto sociale – che avrebbe dovuto conferire legittimità, secondo lui, alle strutture del potere sovrano degli stati nazionali moderni che andavano storicamente costituendosi in quel periodo. Tale legittimità conseguirebbe, secondo Hobbes, dal fatto che il potere sovrano rappresenterebbe l’unica istanza in grado di impedire il manifestarsi dello stato di belligeranza reciproca permanente connaturato nell’uomo.
Ciò che questo breve contributo si propone di mostrare è proprio l’importanza di saper distinguere – nel caso di Hobbes, ma anche e soprattutto in casi più recenti e spesso più sottili – fra il contenuto epistemico oggettivo di una determinata forma di conoscenza scientifica ed i riverberi (se non addirittura abusi) ideologici che accompagnano tale forma di sapere. La legittimazione di strutture di potere o di diseguaglianze sociali sulla base di una presunta complessione della natura umana è infatti caratteristica della società borghese moderna, nella quale l’appello ad istanze metafisiche o trascendenti immaginate essere alla base dell’ordine sociale ha perso la funzione che esso poteva avere in società premoderne. Il senso critico ed un atteggiamento scettico nei confronti di chi si richiama ai risultati della scienza empirica per affermare l’inevitabilità e la naturalità di gerarchie sociali, strutture di dominazione ed altre forme di diseguaglianza rappresenta in questo senso una virtù epistemica fondamentale.
Un esempio particolarmente chiaro di come la linea di discrimine fra il contenuto epistemico oggettivo della scienza ed i riverberi ideologici della stessa possa essere particolarmente difficile da tracciare in maniera univoca è quello della genetica moderna. La scoperta delle leggi dell’eredità da parte di Gregor Mendel (1865) e quella della struttura molecolare del DNA da parte di James Watson e Francis Crick (1953) rappresentano solo gli esempi più eclatanti del successo empirico della scienza dell’eredità biologica. Allo stesso tempo, tali conoscenze empiriche sono state spesso messe al servizio di progetti biopolitici pericolosi come ad esempio l’eugenetica. Nelle due sezioni seguenti, il contributo affronta in una prima tappa l’interpretazione dei contenuti più prettamente fattuali della biologia molecolare moderna, e poi, in una seconda tappa, il caso specifico del razzismo nell’era post-genomica, in cui il pericoloso connubio fra scienza ed ideologia si manifesta in maniera particolarmente evidente.
-
Il DNA: motore immobile della biologia umana?
In un articolo dal titolo Aristotle-totle-totle pubblicato nel 19711, il biofisico tedesco-americano Max Delbrück propose, fra il serio ed il faceto, di fare di Aristotele e della sua teoria della generazione, tale che essa viene sviluppata negli scritti biologici dello stagirita ed in particolare nel De generatione animalium, lo scopritore di quello che secondo Delbrück stesso sarebbe il principio fondamentale della biologia moderna: l’idea che esista un’entità (la causa formale di Aristotele ovvero il DNA della biologia molecolare moderna) che conterrebbe tutta l’informazione necessaria affinché un organismo possa svilupparsi secondo un piano prestabilito (una causa finale, ovvero un “programma”, per riprendere un concetto introdotto proprio a cavallo fra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso da François Jacob e da Ernst Mayr). Secondo Delbrück, Aristotele avrebbe formulato tale principio biologico in una fase intermedia del suo percorso filosofico, successiva al lungo periodo di formazione nell’accademia platonica (durato vent’anni) ma precedente al suo ritorno ad Atene ed alla fondazione della sua propria scuola (il Peripato). Secondo Delbrück sarebbero stati proprio gli studi zoologici e botanici condotti in tale fase in compagnia di Teofrasto – in parte in Macedonia, in parte sulle isole dell’Egeo, in particolare a Lesbo – che avrebbero portato Aristotele alla formulazione del principio della causa formale. La sistematizzazione metafisica che tale principio trova nelle opere della maturità sarebbe dunque successiva alla sua applicazione in ambito biologico, e non viceversa.
Delbrück si spinge fino ad affermare che l’idea stessa del “motore immobile”, che si trova alla base delle concezioni astronomiche e cosmologico-teologiche sviluppate da Aristotele nella Fisica e nella Metafisica, non sarebbe altro che una trasposizione di una teoria originalmente biologica, quella sviluppata in particolare nei capitoli 21 e 22 del libro I del De generatione animalium, in cui Aristotele espone i suoi argomenti in sostegno della tesi secondo cui il seme maschile sarebbe il principio dal quale deriverebbero “la figura e la forma” (ἡ μορφὴ καὶ τὸ εἶδος, G.A. 730b14) dell’embrione oggetto d’indagine. Secondo Delbrück, Aristotele concepirebbe qui l’informazione contenuta nel seme maschile come un motore immobile, in grado di dare avvio allo sviluppo ontogenetico di un nuovo organismo senza venire esso stesso modificato da tale processo, in modo tale da poter poi essere trasmesso alla generazione successiva.
Ciò che la biologia molecolare moderna avrebbe in comune con la teoria aristotelica sarebbe proprio questa concezione dell’informazione biologica quale motore immobile, laddove il ruolo che lo stagirita attribuiva al seme maschile sarebbe ormai da assegnare alla sequenza di nucleotidi contenuta nel nostro DNA. L’informazione genetica determinata da tale sequenza di nucleotidi sarebbe da una parte motore dello sviluppo ontogenetico, dal momento che i geni conterrebbero il “programma” capace di determinare il fenotipo morfologico, fisiologico e comportamentale del nuovo organismo. Dall’altra tale informazione rimarrebbe immobile, nel senso che le proprietà fisico-chimiche del DNA – la cui struttura è quella di un “cristallo aperiodico” (per riprendere un concetto introdotto da Schrödinger nel suo testo What is life? del 1944) – lo renderebbero una molecola particolarmente stabile in grado di trasmettere l’informazione genetica da una generazione all’altra senza quasi errore alcuno.
Nonostante ci sia del vero in entrambe le parti di tale doppia tesi, gli sviluppi della biologia negli ultimi decenni rivelano un quadro assai più complesso, come mostrato ad esempio dal breve libro Il secolo del gene della biologa ed epistemologa femminista Evelyn Fox Keller (2000). Per cominciare dalla tesi dell’“immobilità” del DNA, la sua stabilità molecolare intrinseca non è che uno dei fattori che contribuisce ad una trasmissione dell’informazione genetica quasi priva di errori. In effetti, nonostante la sua stabilità molecolare intrinseca, il DNA è soggetto a diversi episodi di mutazione, tanto spontanea quanto indotta da agenti mutageni (quali ad esempio la luce ultravioletta), e che possono concernere tanto singoli nucleotidi (mutazioni puntiformi) quanto interi cromosomi o addirittura la totalità del genoma. Nel corso dell’evoluzione, gli organismi sviluppatisi sulla terra hanno inventato tutta una serie di meccanismi di riparazione del DNA che hanno permesso loro di abbassare ulteriormente il tasso di mutazione di diversi ordini di grandezza. Il punto importante è che la fedeltà nella trasmissione dell’informazione genetica (vale a dire l’“immobilità” della stessa) non è una proprietà intrinseca della struttura molecolare del DNA, bensì una conseguenza della complessa organizzazione della cellula vivente nella sua totalità, al punto che alcuni tipi di batteri, in condizioni ambientali particolarmente ostili, possiedono addirittura la capacità di “silenziare” alcuni dei loro meccanismi di riparazione per incrementare il tasso di mutazione e di conseguenza la loro “evolvabilità” (vale a dire la loro capacità di generare mutazioni utili alla sopravvivenza).
Ancora più problematica è l’altra tesi, quella del DNA quale “motore” dello sviluppo ontogenetico. Come è ben noto, i geni contenuti nel DNA non sono altro che sequenze di “triplette” di nucleotidi (ATC TCG GTA ecc.) che “codificano” ognuna un determinato aminoacido. La catena causale che conduce dall’informazione genetica contenuta nel DNA al fenotipo morfologico, fisiologico e comportamentale di un determinato organismo è estremamente complessa, in particolare negli organismi eucarioti pluricellulari. Innanzitutto, una determinata sequenza di nucleotidi che viene trascritta in maniera unitaria può essere soggetta ad un processo chiamato splicing alternativo, nel quale segmenti codificanti (esoni) alternativi possono generare degli RNA messaggeri maturi differenti che vengono poi traslati in proteine differenti. Inoltre, anche la stessa proteina può svolgere funzioni del tutto diverse a seconda del contesto in cui essa si trova (ad esempio a seconda del tessuto in cui essa viene prodotta). Una delle scoperte più sorprendenti della biologia dello sviluppo evolutiva (evo-devo) è che le differenze maggiori fra i diversi tipi di organismi pluricellulari che popolano il globo terraqueo non è dovuta tanto a differenze nella sequenza degli aminoacidi nelle loro proteine, che sono sorprendentemente simili anche in organismi appartenenti a gruppi filogenetici molto diversi (quali gli artropodi e i vertebrati, ad esempio), quanto piuttosto alla diversa struttura della rete di regolazione genetica che determina quando, dove, ed in quale quantità una determinata proteina deve venire prodotta. Il “programma” ontogenetico non è dunque localizzato nei singoli geni (nemmeno nella loro somma mereologica), bensì diffuso su diversi livelli dell’organizzazione biologica, e manifesta così proprietà emergenti come ad esempio evolvabilità, robustezza e plasticità.
Alla luce di queste considerazioni, la proposta esegetica di Delbrück, secondo cui la teoria della generazione di Aristotele anticiperebbe il principio fondamentale della biologia molecolare moderna (il suo “dogma centrale”, per riprendere un’espressione di Francis Crick), deve venire respinta: il DNA, lungi dall’essere il motore immobile dello sviluppo e dell’evoluzione biologici, non è che una componente causale fra tante (sebbene una componente particolarmente centrale) in una rete di interazioni complesse in cui l’applicazione dei termini stessi di “informazione” e “programma” può risultare problematica e rimane spesso più metaforica che non fattualmente fondata.
-
Un caso recente: il razzismo nell’era post-genomica
L’appello ad una presunta “natura umana” iscritta nei nostri geni rappresenta la forma più recente del biologismo sociale caratterizzante le strutture di dominazione politica e sociale della società borghese moderna. Mentre in Hobbes la natura fondamentalmente aggressiva ed egoistica dell’animale umano sarebbe una sorta di costante antropologica, condivisa da tutti i membri della nostra specie senza limitazioni geografiche o temporali, e dunque in grado di conferire legittimità universale al potere sovrano del leviatano, le forme più recenti di biologismo sociale si propongono piuttosto di dare un fondamento oggettivo alle diseguaglianze sociali ed economiche richiamandosi a pretese differenze nella costituzione biologica – e più specificamente genetica – dei membri di una determinata società. Il razzismo – vale a dire l’idea che la specie umana possa essere suddivisa in sottopopolazioni che si distinguerebbero biologicamente le une dalle altre in maniera significativa e che tali differenze sarebbero il fondamento di differenze significative anche nel livello intellettuale, culturale e morale di tali popolazioni, in grado di giustificare forme di dominazione coloniale o altri tipi di esclusione e discriminazione politica e sociale – non è che una delle manifestazioni del biologismo sociale moderno. Come mostrato dai biologi Stephen Jay Gould e Richard Lewontin, un'altra forma di determinismo genetico particolarmente perniciosa è quella legata ai tentativi di dare un fondamento biologico alle differenze nel quoziente intellettivo, in modo da poter affermare la naturalità delle importanti differenze di reddito economico che caratterizzano la società capitalistica. Le considerazioni che seguono, pur rapportandosi al caso specifico del razzismo, potrebbero, mutatis mutandis, essere estese anche ad altre forme di biologismo sociale.
Prima di passare ad una disamina critica di una delle manifestazioni più recenti dei tentativi di dare una base scientifica all’idea che l’umanità sia suddivisa in razze, un breve richiamo di quelli che sono gli assunti teoretici ed i fatti empirici sui quali regna consenso nella comunità scientifica è necessario. È noto che la teoria dell’evoluzione di Darwin ed i modelli matematici sviluppati dalla genetica delle popolazioni negli anni ’30 del ventesimo secolo attribuiscono un'importanza fondamentale alla variazione fenotipica e genetica presente in una determinata specie biologica, dal momento che l’azione della selezione naturale presuppone la presenza di tale variazione fenotipica ereditaria. Tale formulazione generale, però, non dice ancora nulla su quanta variazione sia effettivamente presente in una determinata specie biologica (ad esempio nella specie umana) e soprattutto di come tale variazione sia distribuita nelle diverse popolazioni in cui la specie umana è suddivisa. Quando negli anni ‘70 i progressi tecnologici resero possibile una misurazione empirica del grado di polimorfismo genetico presente in e fra diverse popolazioni umane, uno dei resultati importanti che emersero – soprattutto attraverso i lavori di Richard Lewontin – fu la scoperta che la parte più importante di tale variazione (il 90%) è presente all’interno di tali popolazioni, mentre solo una piccola parte (il 10%) rappresenta variazione fra una popolazione e l’altra. Questa differenza fra variazione intra-popolazione e variazione inter-popolazione rappresenta un primo argomento importante contro la possibilità di suddividere la specie umana in sottopopolazioni che si distinguerebbero in maniera biologicamente significativa le une dalle altre.
Recentemente, in seguito al sequenziamento completo del primo genoma umano, completato nell’anno 2000, e poi al progetto dei “mille genomi” – l’idea di sequenziare genomi di diverse popolazioni umane per poterli comparare gli uni con gli altri – l’idea che la specie umana possa essere effettivamente suddivisa in gruppi razziali significativamente differenti gli uni dagli altri ha pericolosamente ricevuto nuovo vigore. In particolare, nel paper Genetic structure of human populations (pubblicato su Science nel 2002), Rosenberg et al. hanno applicato la tecnica matematica del clustering all’indagine statistica delle dissimilarità fra 1056 genomi appartenenti a 52 popolazioni umane provenienti dai cinque continenti, prendendo in considerazione quasi mille loci genetici polimorfici (783 short tandem repeats e 210 indels). Con un parametro di clustering (numero di gruppi statistici ottenuti come output) K = 5, gli autori di tale studio hanno ottenuto una suddivisione della specie umana in sottogruppi corrispondenti geograficamente ai cinque continenti.
Il passo da tale “scoperta” all’affermazione che esistono fondamentalmente cinque razze umane e che la storia culturale, politica ed intellettuale dell’umanità, tanto quella passata come quella presente e futura, sia determinata da queste presunte differenze razziali, è breve, ed è stato effettivamente compiuto dal giornalista scientifico Nicholas Wade. Nel suo libro Troublesome Inheritance (2015), le idee appena schizzate vengono ampiamente sviluppate, fondandosi fra l’altro sull’affermazione che una parte importante della variazione fra popolazioni umane sarebbe dovuta alla selezione naturale ed avrebbe dunque valore adattivo.
Tanto gli studi di Rosenberg quanto il libro di Wade sono stati oggetto di critica da parte di diversi autori2. Un primo punto di critica concerne la legittimità dell’uso delle tecniche di clustering nel caso di un insieme di dati che mostra una variazione clinale, vale a dire laddove la variazione è continua e graduale. Se si stabilisce arbitrariamente un certo numero K e si programma un software in modo tale da suddividere i dati in un numero corrispondente di clusters, è evidente che le suddivisioni ottenute come output saranno non meno arbitrarie del numero K immesso come input. Scegliendo un numero K maggiore si otterrebbero più clusters, ed il carattere clinale della variazione genetica fra popolazioni umane ha come conseguenza che nessuna di queste suddivisioni arbitrarie sia realmente significativa a livello biologico, rappresentando piuttosto un artefatto statistico. Inoltre, l’affermazione di Wade secondo cui una parte importante della variazione genetica fra le popolazioni umane sarebbe dovuta all’azione della selezione naturale ed avrebbe dunque carattere adattativo va anch’essa ridimensionata.
Più generalmente, come mostrato nella prima parte del contributo sull’impossibilità di concepire l’informazione genetica quale “motore immobile” dello sviluppo e dell’evoluzione biologici, il problema principale di tentativi come quello di Wade di mobilitare i risultati della scienza empirica (o piuttosto di artefatti statistici di dubbio valore conoscitivo) al servizio dell’ideologia razzista è che le differenze genetiche che possono essere rintracciate fra popolazioni umane hanno un valore predittivo relativamente esiguo rispetto al fenotipo comportamentale di tali popolazioni. Dal momento che il comportamento culturale ed intellettuale ed il tipo di istituzioni sociali e politiche di una determinata popolazione umana ha, in ragione della plasticità fenotipica dell’animale umano, una relazione molto debole se non nulla con la composizione genetica di tale popolazione, gli argomenti razzisti di Wade sono privi di qualsiasi valore scientifico.
Per concludere, questo esempio recente di cattiva scienza e di abuso ideologico della stessa mostra come la capacità di rimanere critici e di mantenere un atteggiamento scettico nei confronti di pretesi risultati della ricerca empirica costituisca una virtù epistemica fondamentale con importanti implicazioni politiche e sociali. È il compito della filosofia di sapere coltivare tale senso critico e soprattutto di educare al dubbio, anche nei confronti della scienza. De omnibus dubitandum.
1 Disponibile al link seguente: https://www.ini.uzh.ch/~tobi/fun/max/delbruckAristotleTotleTotle1971.pdf.
2 Si veda ad esempio il libro Troublesome science: the misuse of genetics and genomics in understanding race di Rob DeSalle and Ian Tattersall (New York: Columbia University Press, 2018).